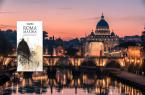Una porta nei crocevia della storia
Perfettamente incastonato nelle Mura Aureliane, tra le più estese e meglio conservate fortificazioni del mondo antico, un semplice ed elegante arco di travertino affiancato da torri fa da spartiacque a un crocevia trafficato tra Villa Borghese e via Veneto, la strada simbolo della Dolce Vita. È Porta Pinciana, una delle poche porte di Roma ad aver conservato inalterato nel tempo il proprio aspetto originale, fatta eccezione per i fornici laterali aperti in epoca moderna per ragioni di viabilità. Nata senza fastosità, alla fine del III secolo – all’epoca cioè della costruzione delle mura da parte dell’imperatore Aureliano – era solo una posterula, un passaggio pedonale di terz’ordine. Appena un secolo dopo, però, la minaccia sempre più pressante delle popolazioni barbariche aveva convinto l’imperatore Onorio a rialzare l’intera cinta muraria e a rinforzare le porte, aggiungendo torri difensive, merlature e posti di guardia nei tratti che ne erano sguarniti, come appunto a Porta Pinciana o a Porta Asinaria. Con le sue due nuove torri tondeggianti e stranamente asimmetriche e la sua posizione in cima al colle del Pincio, la porta si sarebbe rivelata di importanza strategica almeno in un caso, durante il fallito assedio della città a opera degli Ostrogoti di Vitige.
Pinciana, Salaria, Turata, Belisaria…
Il suo nome deriva dalla gens Pincia che nel IV secolo possedeva il colle sulle cui ripidi pendici si appoggiavano le mura in cui apriva, ma nei secoli la porta ha avuto anche altre denominazioni – Porta Salaria Vetus, per esempio, perché da qui usciva l’antichissima “via del sale” tracciata forse anche prima della nascita di Roma, o Porta Turata, perché più volte murata nel corso della sua lunga storia, nell’VIII secolo come nel 1808. La tradizione popolare medievale le assegnò anche il nome di “Porta Belisaria”: dal punto di vista storico, la porta è in effetti strettamente legata al ricordo del generale bizantino Belisario che tra il 537 e il 538 respinse lungo questo tratto di mura il tentativo di assalto alla città da parte dell’esercito guidato da Vitige durante la lunga guerra greco-gotica. A questo periodo risalgono forse anche la croce greca e la croce latina scolpite nelle chiavi di volta all’esterno e all’interno dell’arco, a significare che la città latina era difesa da un esercito bizantino. Una fortunata leggenda nata nel Medioevo racconta poi che Belisario, caduto in disgrazia per aver partecipato a una congiura contro l’imperatore Giustiniano, spogliato dei suoi beni e fatto accecare, avrebbe trascorso i suoi ultimi anni proprio a Roma, mendicando sulla soglia della porta che era stata l’epicentro della sua gloria. A testimonianza della storia, sulla porta sarebbe stata visibile fino all’Ottocento una scritta graffita che recitava “date obolum Belisario”, una frase divenuta proverbiale della caducità della fama e ripresa nel Settecento anche nel celebre dipinto “Belisario chiede l’elemosina” del pittore francese Jacques-Louis David.
Da Belisario a Christo
Dedicato a Belisario (o ad Alessandro Magno) era forse anche l’enorme busto marmoreo che possiamo ammirare ancora oggi in una nicchia a poca distanza dalla porta: prima dell’apertura di via Veneto e della costruzione del quartiere che le gravita intorno, la composizione faceva da sfondo a uno degli ampi viali alberati della spettacolare Villa Ludovisi, sacrificata poco dopo l’unità d’Italia sull’altare della speculazione edilizia. La villa era stata costruita nel Seicento dal cardinale Ludovico Ludovisi, nipote di papa Gregorio XV, e i suoi giardini lambivano il tratto di mura intorno alla porta, mai particolarmente importante dal punto di vista del traffico cittadino. Dalla fine dell’Ottocento, nel camminamento delle mura da Porta Pinciana a Porta Salaria (riaperto al pubblico nel 2021) ebbero poi sede studi e abitazioni di artisti, per esempio quello di Ettore Ferrari, autore del monumento a Giordano Bruno a Campo de’ Fiori. L’esperimento più particolare fu però quello del ceramista Francesco Randone che nella Torre XXXIX di via Campania aprì nel 1890 una scuola “gratuita per le bambine e i bambini dai sei anni ai quindici, senza distinzione di ceto, di religione, di cultura”: la Scuola d’Arte Educatrice, ancora oggi in attività. Nel gennaio del 1974, la porta fu infine protagonista per quaranta giorni di uno spettacolare intervento di land art: in quattro giorni, gli artisti Christo e Jeanne-Claude de Guillebon avvolsero entrambi i lati delle mura con teli di nylon e corde arancioni in uno dei loro famosi “impacchettamenti” temporanei che nascondevano alla vista e trasformavano momentaneamente la realtà, per donare agli osservatori una nuova consapevolezza.
Foto turismoroma
Informazioni
 Condividi
Condividi
Location
Per conoscere tutti servizi sull'accessibilità visita la sezione Roma accessibile.